
Dal seme della koinè culturale grecofona, piantato nel corso della dominazione bizantina allo scopo di rivendicare un lembo strategico del Salento deputato all’accoglienza dei nuovi coloni emigrati dalla Grecia, germogliò l’albero di Calimera, il cui toponimo deriverebbe dal greco kalos (bello) ed emera (giorno)
con il significato benaugurale di buongiorno oppure sempre dal greco kallá (bella) e meréa (contrada) con l’intento di indicare un luogo ameno baciato dal sole e immerso nella natura. Un sole raggiante come quello inquartato sull’arme civica in segno di auspicio di vita eterna, regalità e prosperità.
Secondo la leggenda, molto lontana dalla verità storica, Calimera sarebbe stata fondata in una grande vallata circondata da fitti boschi da alcuni possidenti di Martano, i quali, in concomitanza del loro trasferimento nelle dimore di villeggiatura, edificate in luoghi bucolici dove si respirava a pieni polmoni aria salubre, volevano ricorrere all’espressione grika Pame sti Kalimera, ossia andiamo al buon giorno per abbandonarci al relax e agli ozi.
Il bosco, costellato di lecceti e querceti di rovere, oltre a costituire un polmone verde contribuì alla fioritura delle lucrose attività dei carbonai (craunari) coadiuvati dai focari specializzati nell’allestimento in loco delle carbonaie necessarie a trasformare la legna in carbone. Al loro protettore San Biagio, intorno all’anno Mille, venne dedicata una chiesa scavata nella roccia e affrescata nel corso del Settecento con la figura del santo vescovo invocato anche per guarire dai mali della gola. Residuo di laura basiliana, una volta trasformata in stalla, cadde nel più completo degrado in cui continua a versare tuttora a ridosso dell’area naturalistico-archeologica punteggiata, lungo la strada poderale, di edicole votive e fosse granarie per il deposito dei cereali. A ricavare cospicue rendite dal bosco, sulla base di un documento del 1468, i soliti notabili: nobili ed ecclesiastici, che vietavano alla povera gente di tagliare la legna oltre ad interdire il pascolo ai pastori.
A causa della scarsità delle fonti documentarie e d’archivio risulta alquanto ardua la ricostruzione delle successioni feudali, gravitanti intorno ai baroni De Hugot, Gesualdo, Soriano e Bucali, anche se, intorno alla metà del XVI secolo, il feudo ricadeva tra i possedimenti del marchese Delli Monti. In seguito venne acquistato dal facoltoso signore di Tutino, Luigi Trane, per poi transitare dal duca Lorenzo Brunossi al marchese Sebastiano Gadaleta.
Attraverso i solchi lacerati dalle ruote dei carri, che percorrevano un tratto dell’asse viario romano della Traiana Calabra (collegante Brindisi a Lecce sino ad Otranto), continuò a scorrere lentamente la vita del casale medievale documentato da sepolture, fovee e cripte rupestri. Intorno all’XI secolo il terrore di essere spazzati via da nemici sempre in agguato spinse un pugno di abitanti a fondare un villaggio aperto, che, con la colonizzazione bizantina entrò nella sfera d’influenza del monastero di San Nicola di Casole. La commistione con i coloni e i monaci greci spianò la strada all’affermazione incontrastata del rito greco ortodosso oltre alla diffusione della lingua ellenofona tramandata di generazione in generazione soprattutto dalle donne, vestali delle tradizioni alimentate intorno alla fiamma del focolare. Una fiamma ravvivata ancora oggi nella penombra delle stanze della Casa-Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Grika predisposta dal 2003 dal Circolo Culturale Ghetonìa come luogo simbolo dell’antica sapienza popolare. In questo luogo di memorie sono conservati oggetti della cultura materiale, reperti archeologici, attrezzi agricoli, strumenti della filatura e della tessitura utili al confezionamento della dote da esibire in concomitanza del matrimonio, raccolte di libri e spartiti musicali relativi a canti d’amore e di lavoro nei campi; preziose testimonianze di vita scandita da regole arcaiche difficili da estirpare come lo fu il rito greco.
Nonostante i dettami del Concilio di Trento la liturgia greca convisse pacificamente con quella latina, così come testimoniato dall’affresco raffigurante la Madonna di Costantinopoli scampato alla demolizione dell’omonima chiesa nella prima metà del Novecento. Il brano pittorico, riferibile al 1603, raffigurava due vescovi in abiti pontificali, l’occidentale Sant’Eligio e l’orientale Sant’Elia. Secondo le fonti l’ultimo protopapás di Calimera, Sigismondo o Gismondo De Matteis, venne assassinato nel 1621 da sicari per essere sostituito da un parroco latino, don Troylo Licci. Nel marasma del rinnovamento l’antico luogo di culto greco venne raso al suolo per procedere nel 1689 con l’edificazione sulle sue vestigia della chiesa matrice intitolata a San Brizio venerato come protettore.
Il tempio di stampo tardo rinascimentale, ripartito in due ordini, nel 1692 venne corredato di un elegante portale barocco, coronato dallo stemma civico con il sole recante un cartiglio con l’epigrafe EN/CONFVGIVM AC/ NVMINEM/ QVI TVTELA POPVLI HVIVS sormontato a sua volta dal simulacro di San Brizio. La luce venne fatta filtrare attraverso un ampio finestrone, mentre sulle fasce laterali vennero ricavate due nicchie poste in asse a due cartigli incastonati sul secondo ordine. Quello a sinistra recitava: DOM/ TEMPORIS VETVS/TATE RIMANS SOLIQVA/ AVGVSTA LABORANS/ PRIMAEVUM VNIVERSITATIS IVRIS PATRONATVS/ TEMPLVM; quello a destra: PERAMPLIVS/ ET PERFECTIVS DENVO/ AERE SVO SVB AVSPICIO DIVI/ BRITII. PREDICAT ET SACRAT/ POPVLVS ISTE/ A.D. MDCLXXXVIII, documentando l’ampliamento realizzato dal 1688 al 1692. Alle spalle dell’edificio sacro nel XVIII secolo venne innalzata la torre campanaria, svettante simbolicamente verso il cielo, in quattro ordini, di cui l’ultimo culminante con un cupolino ottagonale. L’interno dell’edificio sacro a croce latina venne armonicamente scandito da otto altari laterali, impreziositi con tele di un certo valore artistico come quella raffigurante la Madonna della Misericordia, ritratta in via del tutto eccezionale con in grembo Gesù, dal celebre pittore gallipolino Giovan Domenico Catalano. Nella zona absidale, occupata dall’altare maggiore, la quinta scenografica venne esaltata con l’installazione di una splendida cantoria. Nel 1984 durante i lavori di rifacimento del pavimento vennero rinvenuti cinque ossari e quattro loculi tombali, il cui accesso era consentito da botole.
Dopo la chiesa matrice per dimensioni si attesta la cappella dell’Immacolata risalente al 1636. A navata unica e voltata a botte lunettata si presenta decorata al centro della volta con un affresco della titolare e pavimentata con mattonelle maiolicate. Di pregevole fattura l’altare maggiore in stile tardo barocco coronato da un fastigio, dove è incassato il medaglione decorato con l’Annunciazione dell’arcangelo Gabriele.
Uno scrigno di tesori da dischiudere rimane la Cappella del Crocefisso. Incredibilmente austera all’esterno si presenta ricca all’interno in virtù dei suoi affreschi, che si dipanano lungo la volta a spigolo e il settore absidale interessato dall’iscrizione OMNIS FIGVRA / EIVS AMOREM / SPIRAT ET AD / REDAMADVM / PROVOCAT 1698. Ad aula unica venne commissionata dalla nobile famiglia Licci, che la elesse a cappella gentilizia oltre a manifesto di ostentazione, di potere e di benessere sociale. Rapisce lo sguardo la volta, affrescata con i quattro evangelisti ispirati dal soffio dello Spirito Santo, e l’altare dominato da un massiccio Crocifisso ligneo del Seicento, attribuito al maestro alessanese Placido Buffelli.
Alla raffinata devozione dei signori si contrapponeva quella intrisa di superstizione dei cafoni particolarmente devoti a San Vito martire, invocato per allontanare la rabbia, la peste e le malattie contagiose. Alla periferia di Calimera, ai margini dell’antico bosco, sorgeva la cappella intitolata al santo taumaturgo descritta in occasione di diverse visite pastorali, come, ad esempio, quella del 1608, che menzionava tre altari. Ad essa si accedeva attraverso un portale, sul quale era incisa l’iscrizione VINCVLVM PERFECTIONIS CHARITAS 1684. Secondo la tradizione popolare l’edificio sacro, sormontato da uno slanciato campanile a vela, venne costruito intorno ad una pietra forata, denominata mehn-al-tol, rientrante nel panorama dei monumenti megalitici (dolmen e menhir) sparsi in tutta Europa e ancorati al ricordo ancestrale del passaggio da comunità di pastori a comunità di agricoltori impegnate a calcolare solstizi e fasi lunari oltre ad adorare le pietre convertite in altari. Silenziosa testimone di culti preistorici connessi alla fertilità la pietra forata di San Vito rimane un cordone ombelicale con i rituali pagani, che, seppur sterminati dal cristianesimo, hanno resistito saldamente nei contesti più arretrati e isolati, dove si praticava un’agricoltura di sussistenza. Da secoli puntualmente ogni anno il lunedì dell’Angelo si rinnova il rito propiziatorio attraverso il foro della sacra roccia nel solco di un retaggio atavico impossibile da rescindere.
Un’altra suggestiva tradizione popolare, celebrata nella ricorrenza del solstizio d’estate, si annida nella Festa dei Lampioni dedicata a San Luigi Gonzaga. Essa rappresentava un tempo l’occasione per portare alla ribalta colorati lampioni di carta dalle forme fantasiose, che venivano illuminati con tremule candele e appesi ai balconi del centro storico vibrante di luce e di speranza per il ritorno della bella stagione.
Nelle campagne, tra le bionde spighe di grano da mietere e le verdi foglie di tabacco da essiccare, i contadini si abbandonavano a seducenti promesse di raccolti abbondanti, mentre in paese, nelle ore notturne si dischiudevano le porte nascoste dietro gli archi delle case a corte come, ad esempio, quelle di via Mayro, vico San Calimero e San Paolo non solo per trovare refrigerio alla calura, ma anche per tessere vecchie amicizie e nuove storie d’amore di fronte ad un bicchiere di vino ed un pezzo di pane con il pomodoro condito con un pizzico di sale e un filo d’olio extravergine d’oliva. Nel desiderio di conquista e di rivalsa, a colpi di falce e al ritmo dei dischi dell’aratro, la mente volava proprio ai nodosi alberi di ulivo per mantenere alta quantitativamente e qualitativamente la produzione olearia nel centro con il più alto numero di frantoi ipogei di tutta la Grecìa Salentina attivi a pieno regime già sul finire del Seicento.
Pensieri, parole, gesti, silenzi, gioie e dolori quotidiani intimamente rivolti alla terra madre, pregando il cielo di non riversare grandine e gelate, che, in un sol colpo, compromettevano sforzi, sacrifici e privazioni, mettendo in ginocchio l’economia autarchica di famiglie patriarcali abituate a sopravvivere con il sudore della fronte sulla scia degli insegnamenti dei laboriosi antenati, che emigrarono dalla Grecia per trovare una nuova dimora, per venerare le loro immagini sacre bandite da imperatori iconoclasti e per irradiare una gloriosa civiltà, rievocata da una stele marmorea commemorativa proveniente dall’acropoli di Atene e ubicata nel 1960 nella villa comunale tra i busti di illustri calimeresi, tra cui l’erudito locale Vito Domenico Palumbo. Il richiamo magnetico delle comuni origini, orgoglioso vanto di identità sociale, è sprigionato da questo monumento funerario, coronato da una palmetta ed ornato con eleganti rosette. Ad esso Patroclia di Proclide da Atmon nel IV sec. a.C. affidò il ricordo della sua esistenza terrena, scivolando tra le ombre nel regno degli Inferi di una Grecia popolata da uomini con lo sguardo rivolto verso gli dei dell’Olimpo. Nell’archivio della memoria storica calimerese la grecità è sopravvissuta all’oblio, avviluppandosi come l’edera intorno a quel segnacolo, che si infiamma al sole del tramonto, quando i raggi lo accarezzano, rinvigorendone le lontane radici.
testo di Lory Larva
fotografie di Alessandro Romano
FOTOGALLERY CALIMERA
© Questo sito web non ha scopo di lucro, non userà mai banner pubblicitari, si basa solo sul mio impegno personale e su alcuni reportage che mi donano gli amici, tutti i costi vivi sono a mio carico (spostamenti fra le città del territorio salentino e italiano, spese di gestione del sito e del dominio). Se lo avete apprezzato e ritenete di potermi dare una mano a produrre sempre nuovi reportage, mi farà piacere se acquisterete i miei romanzi (trovate i titoli a questa pagina). Tutto ciò che compare sul sito, soprattutto le immagini, non può essere usato in altri contesti che non abbiano altro scopo se non quello gratuito di diffusione di storia, arte e cultura. Come dice la Legge Franceschini, le immagini dei Beni Culturali possono essere divulgate, purché il contenitore non abbia fini commerciali. I diritti dei beni ecclesiastici sono delle varie parrocchie, e le foto presenti in questo sito sono sempre state scattate dopo permesso verbale, e in generale sono tutte marchiate col logo di questo sito unicamente per impedire che esse finiscano scaricate (come da me spesso scoperto) e utilizzate su altri siti o riviste a carattere commerciale. Per quanto riguarda le foto scattate in campagne e masserie abbandonate, se qualche proprietario ne riscontra qualcuna che ritiene di voler cancellare da questo blog (laddove non c’erano cartelli o muri che distinguessero terreno pubblico da quello privato, non ce ne siamo accorti) è pregato (come chiunque altro voglia segnalare rettifiche) di contattarci alla mail info@salentoacolory.it














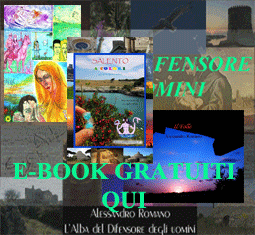









































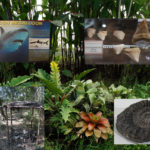

Leave a reply